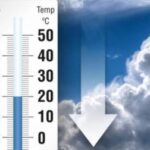«Che cosa sia un intellettuale, nessuno sa con precisione, e infatti neanche noi abbiamo tentato di stabilirlo. Anzi, che il concetto resti nel vago giova al nostro proposito: fare di un qualsiasi giovane sfornito di talento un uomo di successo nel mondo della cultura».
Inizia così una delle sei lezioni che Luciano Biancardi dedicò ai giovani senza particolari doti, che intendono avventurarsi nella carriera del letterato.
Per lunghi anni trascurato, Biancardi è uno degli scrittori più alternativi e avvincenti del secondo novecento italiano. Grossetano, arruolato nel 1943, risalì il paese insieme alle truppe inglesi offrendosi come traduttore.
Laureatosi in filosofia, aderì al partito d’azione, quindi scappò dalla provincia, direzione Milano dove trovò lavoro e amante.
Assunto da Feltrinelli, venne licenziato per poca produttività, ma fu proprio la casa editrice di Milano a pubblicare i suoi primi libri. Il successo arrivò nel 1964 con il romanzo “La vita agra” (edito da Rizzoli) che ottenne il plauso di Montanelli che lo chiamò al Corriere della sera. Invito che Bianciardi ebbe l’ardire di rifiutare.
Preferì scrivere su “Il Giorno” e su riviste come Playmen, Il Guerin Sportivo e l’anticonformista periodico “ABC” dove tenne la rubrica “Telebianciardi”. E proprio su ABC, nel 1966, vennero pubblicate le sei lezioni che NeriPozza ha recuperato e messo insieme nel pamphlet “Non leggete i libri, fateveli raccontare”, suggerimenti invecchiati così bene da sembrare scritti ieri.
E siccome i giovani privi di talento ma desiderosi di carriera sono una specie mai estinta, i consigli di Bianciardi sono ancora utili. Iscriversi ad una facoltà indefinita senza l’ambizione di terminarla, sposare (in chiesa) una donna più anziana per carpirne i segreti dell’esperienza, gesticolare nel modo giusto, fumare la pipa, vestirsi con sobria eleganza, aggiungere pause al discorso ma soprattutto evitare di leggere libri.
“Nessuna persona seria e pratica oggi vuole formarsi: basta informarsi” scrive Bianciardi. Una perla.
Ma siccome occorre anche sapere cosa dire, il Nostro giovine abbia cura di saper ascoltare gli amici ben inseriti. Poi basterà ripetere, rimanendo nel vago, per discorrere di qualsiasi argomento. Anche politico, ma senza schierarsi mai.
Fondamentale sarà entrare a far parte di un qualche cenacolo, circolo o gruppo culturale e farsi eleggere, non presidente e nemmeno segretario, ma vicepresidente.
“Il vicepresidente raccoglie il merito delle iniziative, quando le cose funzionano. Apre i dibattiti e li presiede (…) la gente uscirà dalla serata con la convinzione che il più in gamba di tutti è proprio lui”.
La rabbia sociale che ne fece prima un paladino dei diritti dei deboli e che in età adulta diverrà vivace autoironia, si mostra più chiaramente negli ultimi due capitoli, dove il Nostro va a confrontarsi con la piramide aziendale e la vita d’ufficio, producendosi in un’attenta analisi del neopadrone (dottrina che battezza “bossologia”).
Una tensione sociale, questa, che Bianciardi coltivò per tutta la sua vita mischiandola con un’allergia ai potenti che lo tenne lontano dai più influenti circuiti intellettuali e soffocandola, poi, con massicce aliquote di humour nero e altrettante poderose dosi di Campari e grappa gialla.
Tanto che, quando finalmente arrivò la rivoluzione sessantottina, lui si fece trovare impreparato. D’altronde dal più antimoderno degli scrittori novecenteschi, c’era da aspettarselo.
“Non leggete i libri, fateveli raccontare” andrebbe letto, riletto e opportunamente regalato.
Bianciardi morì di cirrosi epatica, nel 1971, a soli 49 anni. Secondo le cronache, a chi gli stava vicino, prima di andarsene, ripeteva: “sopportatemi, duro ancora poco”.
Ma, per fortuna, son rimasti i suoi libri.
FOLLOW ME ON TWITTER: @chrideiuliis – search me on LINKEDIN