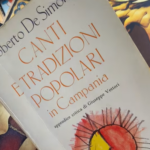Il mostro che dava le sue vittime in pasto ai maiali
Ernesto Picchioni è stato il primo assassino seriale italiano del ‘900.
Per attirare le sue vittime tesseva una “tela”, che le costringeva a entrare nella sua casa.
Chiodi, candele e una casa accogliente: erano gli ingredienti che Ernesto Picchioni, ribattezzato dalle cronache “il mostro di Nerola”, utilizzava per attirare le sue vittime in trappola; Nerola è un piccolo Comune dell’hinterland romano.
Picchioni aspettava le sue vittime, come fa un ragno con le mosche, dopo aver tessuto la tela; poi le colpiva, le uccideva, rubava tutto quello che possedevano e le seppelliva in giardino.
Così, il chilometro 47 della via Salaria, che da Roma porta a Porto d’Ascoli sul Mare Adriatico, divenne tristemente noto negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quando Picchioni iniziò a colpire.
“E’ stato il primo serial killer italiano della storia moderna”, ha scritto su” Il giornale.it “ la giornalista Rita Cavallaro, autrice, insieme a Emilio Orlando, nel libro “22 gradini per l’inferno. Dal mostro di Nerola al depezzatore di Roma. I serial killer italiani nella scala del male“, edito da Male Edizioni, che analizza gli assassini seriali italiani, per capirne il grado di malvagità.
“Lui, nonostante abbia commesso molti delitti in maniera efferata – continua la giornalista – non si pone a un livello alto della scala del male, perché non agiva per piacere o impulsi sadici, ma uccideva per profitto”.
Ernesto Picchioni era nato a nel 1906 a Ascrea (Rieti), era andato ad abitare vicino a Nerola, in una casa costruita su un terreno che si estendeva al lato della via Salaria.
Durante e immediatamente dopo la guerra, le persone povere e quelle che vivevano nell’emarginazione e nel disagio erano tante, l’uomo che divenne “il mostro di Nerola” era tra queste.
Era un contadino che per vivere, a suo dire, vendeva lumache, era tarchiato, basso, robusto, volto chiuso, come il guscio di una grossa noce, mani grandi e forti, abituate alla zappa e all’aratro, occhi piccoli nascosti sotto sopracciglia folte e sporgenti.
Era una persona senza cultura, appartenente al basso ceto sociale e non aveva un lavoro.
Era un perditempo, passava le giornate senza far nulla se non giocare a dadi, frequentare bische clandestine e andare a bere nelle osterie fino a ubriacarsi.
Viveva in un’abitazione al 47.esimo chilometro della via Salaria insieme alla moglie Filomena e ai loro quattro figli, tre femmine e un maschio, ma quella casa Picchioni l’aveva ottenuta con la forza, aveva aggredito il proprietario del fondo sul quale abitava abusivamente e lo aveva colpito con una pietra.
Per questo era stato condannato a scontare alcuni mesi di carcere, ma poi aveva continuato a vivere in quella casa insieme alla famiglia. E anche lì, nel focolare domestico, Picchioni non risparmiava botte, minacce e insulti; per lui la moglie andava comandata e sottomessa, con botte e soggiogamento psicologico.
Agiva sempre come despota e manipolatore, sia all’interno che all’esterno della famiglia, con minacce per imporre la sua volontà.
Come tesse la tela un ragno?
“Vieni nel mio salotto, disse il ragno alla mosca”, in una poesia scritta nel 1829 da Mary Howitt: il ragno getta l’esca per far cadere in trappola la sua preda, senza muoversi dal suo nascondiglio; così faceva Ernesto Picchioni, ma la sua tela era fatta di chiodi e candele.
Il mostro infatti aveva messo a punto una strategia efficace, che gli permetteva di attirare a sé le sue vittime, che entravano volontariamente in casa sua: buttava dei chiodi per terra sulla strada, e quando qualcuno passava in bicicletta o in motocicletta bucava.
Così chi percorreva la via Salaria si ritrovava con una gomma forata al chilometro 47. Intorno il nulla. Impossibile chiedere aiuto a qualcuno. Ma poi, poco lontano, i malcapitati scorgevano qualcosa, vedevano le luci fioche della sua casa, che Picchioni lasciava accese apposta per questo scopo, perché fossero l’unica cosa che si vedesse nel buio e per attirare così le sue vittime.
Chi era in difficoltà si avvicinava alla sua casa e vi trovava un contadino gentile e disponibile; una volta aperta la porta, Picchioni recitava la sua parte: offriva alle persone aiuto, cibo e vino, poi si offriva di ospitarli per la notte, assicurando loro che l’indomani li avrebbe aiutati a cambiare la gomma.
Ma quando il malcapitato di turno si addormentava, l’assassino entrava nella stanza, lo uccideva e sottraeva alla vittima tutto quello che aveva, soldi, gioielli e lo spogliava anche dei vestiti; poi lo faceva a pezzi, e una parte li sotterrava e l’altra la dava in pasto ai maiali.
Secondo la sentenza di condanna, il Picchioni aveva escogitato una trappola, si legge su un numero dell’ “Unità” di diversi anni dopo la scoperta dei corpi; aspettava le vittime come un ragno al centro di una rete.
Otto furono le vittime ufficialmente accertate, ma, secondo le dichiarazioni della moglie, sarebbero molte di più.
Difficile il riconoscimento dei resti, dato che non si trovarono mai i corpi, perché lui li faceva a pezzi.
Tra le vittime un nome è certo: Pietro Monni, un avvocato di Rieti, scomparso il 5 luglio del 1944.
Quel giorno Monni viaggiava sulla Salaria, diretto a Ponterotto, una frazione a pochi chilometri da Nerola.
Al chilometro 47 un chiodo sulla strada gli fece bucare una gomma. Intorno a lui il nulla, tranne un’abitazione: quella del Picchioni. Il contadino gli aprì la porta, fornendogli aiuto. Poi il “mostro” colpì l’avvocato, lo uccise, lo depredò di ogni avere e seppellì il corpo.”
La ricostruzione dei periti portò alla conclusione che la vittima fosse stata colpita da proiettili multipli di fucile esplosi contro la regione posteriore destra del cranio, che scoppiò.
Quando i carabinieri andarono a scavare riuscirono a identificare solamente il corpo di Pietro Monni.
Sull’omicidio dell’avvocato Monni, Picchioni ammise di averlo ucciso, ma tentò di giustificarsi: “Mentre mangiava cominciammo a discutere. Era un uomo istruito, voleva avere sempre ragione e allora io cominciai a odiarlo, gli urlai degli insulti. Lui mi rispose. Io afferrai un fucile e lo freddai. Poi lo seppellii nell’orto”.
Oltre a quello di Pietro Monni, i giornali dell’epoca fecero anche il nome di Alessandro Daddi, impiegato al Ministero della Difesa e scomparso nel maggio del 1947, mentre si recava a trovare la madre a Contigliano, in provincia di Rieti. Il giorno della scomparsa, Daddi viaggiava a bordo di una bicicletta su cui era stato montato il Cucciolo, un piccolo motore che trasformava la bici in una sorta di motocicletta. Anche il Daddi avrebbe bucato al chilometro 47 della Salaria e avrebbe chiesto aiuto a Picchioni, che lo avrebbe ucciso.
Il mostro avrebbe confessato l’omicidio: “Anche il Daddi bucò, chiese aiuto e fu ucciso. Lui mi insultò e mi aggredì, narrò il Picchioni, era ben più alto di me e, quando stava per buttarmi a terra, riuscii ad afferrare un coltello e a colpirlo alla gola’”.
Gli altri resti ritrovati nel terreno vicino alla casa di Picchioni erano solo pezzi di corpi, e dalle analisi si scoprì che alcuni erano di un adolescente, mentre altri di un signore con i baffi.
Se non fosse stato fermato, Picchioni avrebbe continuato a uccidere, e a fermarlo fu la moglie nell’ottobre del 1947 che lo denunciò e lo fece arrestare.
Se non fosse stato arrestato probabilmente non avrebbe colpito solo persone estranee: I Carabinieri avevano scoperto che aveva già messo in conto anche di sterminare la sua famiglia, sia la moglie che i figli; probabilmente la moglie lo aveva intuito.
Fu così che un giorno Filomena uscì di casa con una scusa e corse alla stazione dei carabinieri e raccontò tutto; la donna parlò degli omicidi, della trappola messa a punto dal marito, che aveva costretto lei e il figlio Angelo a scavare la fossa dell’orto, dentro la quale seppelliva i resti delle sue vittime; confessò di essere stata costretta a seppellire più di un cadavere, sotto la minaccia di fare la stessa fine.
Anche i figli, Angelo di 14 anni, Valeria di 10, Carolina di 8 e Gabriella di 4 e la vecchia madre Clorinda, vivevano sotto l’incubo del malvivente. Infatti una volta il Picchioni aveva costretto la moglie e il figlio più grande a scavare una fossa e poi aveva detto: “Qui ci metterò voi e tutti gli altri se fiaterete”.
Fu forse anche questa paura a spingere Filomena a parlare, e così venne fuori tutto, altrimenti nessuno avrebbe mai immaginato l’orrore che aveva messo in scena in quegli anni il Picchioni, perché a quel tempo, subito dopo la guerra, la scomparsa di una persona non rappresentava un evento straordinario.
Il processo contro “il mostro di Nerola” iniziò nel marzo del 1949 e, in tribunale, la moglie confermò gli orrori commessi dal marito.
Il 13 marzo 1949, la Corte d’Assise di Roma condannò Ernesto Picchioni a due ergastoli e 26 anni di carcere.
I giudici lo ritennero “un simulatore”. Ma, successivamente, il direttore del carcere nel quale il Picchioni scontava la sua pena accertò che l’ergastolano non era completamente padrone di sé e lo fece ricoverare al manicomio giudiziario di Reggio Emilia, dove egli fu trattenuto per quattro anni.
Mentre era in attesa dell’Appello, l’uomo venne sottoposto a una perizia psichiatria, che accertò l’assenza di infermità mentale, che il Picchioni intendeva simulare.
Secondo la perizia psichiatrica “presentava solo le note di una costituzione neurodegenerativa originaria ed esibiva disordini del pensiero e della condotta di natura chiaramente intenzionale”.
Nel 1954 l’Appello confermò la condanna all’ergastolo e nel 1956 la Cassazione rese definitiva la sentenza.
Ernesto Picchioni morì in carcere nel maggio del 1967.