Sebbene la epidemia più terribile di tutte nella storia del mondo sia quella dell’inizio del secolo scorso, la Spagnola, della quale abbiamo già parlato in un articolo precedente, la Peste Bubbonica che più si ricorda è quella del 1630 che fu particolarmente cruenta nelle regioni dell’Italia del Nord.
Essa viene anche definita “La Peste Manzoniana”: fa parte dei nostri ricordi in quanto descritta diffusamente e con dovizia di particolari dal grande romanziere e poeta Alessandro Manzoni nel suo capolavoro “I promessi sposi”, edizione 1840: c’è anche quella precedente del 1827, definita “ventisettana”, il cui testo successivamente il Manzoni andò a “risciacquare in Arno”, per renderlo più aderente al linguaggio fiorentino; ma noi ci riferiamo a quello successivo.
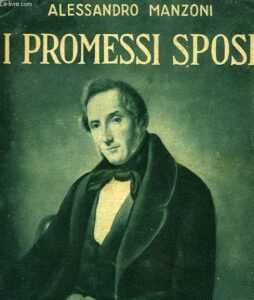 Sebbene l’autore finga di rivolgersi, all’inizio dello stesso, ai suoi 25 lettori, in effetti usò questa espressione retorica per finta modestia in quanto era convinto che anche con “I promessi sposi”, che è la sua opera più importante e il romanzo storico italiano più letto di sempre, avrebbe avuto il successo già riservato a tutte le altre sue opere.
Sebbene l’autore finga di rivolgersi, all’inizio dello stesso, ai suoi 25 lettori, in effetti usò questa espressione retorica per finta modestia in quanto era convinto che anche con “I promessi sposi”, che è la sua opera più importante e il romanzo storico italiano più letto di sempre, avrebbe avuto il successo già riservato a tutte le altre sue opere.
Ed è difficile non farsi coinvolgere nella rilettura de “I promessi sposi” anche per il discorso della Peste del 1630 in quanto la cronaca che il Manzoni fa di quella pestilenza è talmente puntuale, diremmo puntigliosa, che già la sola rilettura dei capitoli ad essa dedicati danno le dimensioni di cosa fosse, all’epoca, un cataclisma del genere.
Con la peste manzoniana morirono più di 1 milione e 100 mila persone, su una popolazione complessiva di 4.milioni circa (il 27,5%), consumate da dolori e disperazione, abbandonate a se stesse o in balia di individui, i Monatti, contagiati dal morbo e poi guariti, che avevano il solo compito di caricare sulle loro carrette i corpi martoriati dei morti da gettare nelle fosse comuni.
Toccante e indimenticabile la scena della piccola Cecilia, che la madre, distrutta dal dolore, affida ai “turpi Monatti” i quali, sebbene abbrutiti dall’abitudine ai corpi dei morti, pure essi provano un senso di pietà di fronte al dolore di quella madre che con tanta dignità affida ad essi la figlia, sapendo che anche lei è condannata e dando ad essi l’appuntamento per un prossimo viaggio per “… prendere anche me e non me sola”.
Quella epidemia, quindi, venne trattata ampiamente nel romanzo del Manzoni, tant’è che occupa una parte sostanziosa dello stesso, ben 9 capitoli (dal 28° al 36°): per l’autore costituì lo scenario sul quale rappresentare la disperazione e la salvezza dei suoi personaggi che, contagiati dalla peste, trovano nella sofferenza il motivo della eterna dannazione o del riscatto, un concentrato di fede e di disperazione che solo una grande penna riesce a rendere tanto evidente.
Ed è impressionante la lettura di quelle pagine, che danno l’impressione del copione di uno spettacolo, tant’è che qualche critico letterario ha scritto che Manzoni usava una specie di tecnica cinematografica per rendere più evidenti scenari e personaggi.
Ma, sebbene difficile, non vogliamo farci ulteriormente coinvolgere dal romanzo del Manzoni e torniamo all’argomento di cui al titolo di questo pezzo.
La epidemia di peste del 1630, imperversò in diverse zone del nord Italia tra il 1629 e il 1633, e si estese dalle Repubbliche di Lucca e della Svizzera fino al Granducato di Toscana. Ma la zona più colpita fu il Ducato di Milano e, in particolare, la capitale, Milano, ed ebbe il suo apice proprio nel 1630.
 Essa venne portata dai Lanzichenecchi, soldati di ventura che parteciparono alla guerra di successione a Vincenzo II di Gonzaga, morto nel 1628, Signore di Mantova e del Monferrato (detta anche seconda guerra del Monferrato e che coinvolse mezza Europa); sembra che a quella guerra abbiano partecipato ben 36 mila uomini di questa soldataglia, dei cui saccheggi e violenze furono vittime le popolazioni che vennero anche contagiate dalla peste.
Essa venne portata dai Lanzichenecchi, soldati di ventura che parteciparono alla guerra di successione a Vincenzo II di Gonzaga, morto nel 1628, Signore di Mantova e del Monferrato (detta anche seconda guerra del Monferrato e che coinvolse mezza Europa); sembra che a quella guerra abbiano partecipato ben 36 mila uomini di questa soldataglia, dei cui saccheggi e violenze furono vittime le popolazioni che vennero anche contagiate dalla peste.
Fortunatamente la pestilenza non scese oltre la Toscana, ed è impressionante l’analogia di quella epidemia con quella attuale.
Nessuna delle regioni del nord Italia fu esente, e in alcune città i morti superarono la percentuale indicata prima; si calcolò che Torino, su 25mila abitanti, contò 8mila morti, e che ci vollero circa due secoli per far tornare la popolazione a quella di prima della pestilenza.
Nel veneziano morirono 150 mila persone, il 40% della popolazione.
Confrontando i dati pervenuti dagli storici con quelli dell’attuale pandemia si rileva che anche allora le città più colpite furono Milano col 74% di decessi rispetto alla popolazione, Verona 61%, Padova 59%, Modena 55%, Parma 50%, Cremona 46%, Brescia 45%, Piacenza 44%: percentuali da capogiro.
Solo nell’inverno del 1630, grazie alla temperatura fredda, la pandemia iniziò a calare, ma si dovette attendere la metà dell’anno successivo perché gradatamente si estinguesse.
 Ma non possiamo chiudere questa breve rievocazione senza menzionare un’altra opera di Alessandro Manzoni, sempre legata alla “sua” peste, e cioè la “Storia della colonna infame”, un libricino che a volte viene stampato come appendice a “I promessi sposi”, altre volte a parte, e che racconta un’altra infamità della quale vennero accusati due ignari personaggi, presunti untori, Guglielmo Piazza, commissario di sanità, e Gian Giacomo Morra, barbiere.
Ma non possiamo chiudere questa breve rievocazione senza menzionare un’altra opera di Alessandro Manzoni, sempre legata alla “sua” peste, e cioè la “Storia della colonna infame”, un libricino che a volte viene stampato come appendice a “I promessi sposi”, altre volte a parte, e che racconta un’altra infamità della quale vennero accusati due ignari personaggi, presunti untori, Guglielmo Piazza, commissario di sanità, e Gian Giacomo Morra, barbiere.
Proprio come oggi, che per taluni personaggi gli untori dell’attuale epidemia sono i cinesi, allora tra gli untori vennero individuati quei due poveretti.
All’epoca la popolazione viveva nella più totale ignoranza e pochi avevano qualche istruzione che potesse far comprendere ciò che il popolino attribuiva a un evento divino (castigo o premio) e, nei casi di pestilenza, a ignobili untori, individui che, secondo la credenza popolare, andavano in giro a infettare, con intrugli magici, la popolazione.
 Una delle dicerie che si diffuse a Milano, fu che due untori fossero proprio il barbiere e il Commissario di sanità, i quali vennero catturati, sottoposti al giudizio della “santa” Inquisizione e, dopo indicibili torture, subirono un processo sommario e furono giustiziati col supplizio della ruota; la bottega del barbiere venne distrutta, e sulle sue macerie venne eretta la colonna infame della quale ancora si conserva traccia nel Castello Sforzesco di Milano.
Una delle dicerie che si diffuse a Milano, fu che due untori fossero proprio il barbiere e il Commissario di sanità, i quali vennero catturati, sottoposti al giudizio della “santa” Inquisizione e, dopo indicibili torture, subirono un processo sommario e furono giustiziati col supplizio della ruota; la bottega del barbiere venne distrutta, e sulle sue macerie venne eretta la colonna infame della quale ancora si conserva traccia nel Castello Sforzesco di Milano.
Oggi all’angolo tra via Gian Giacomo Mora (intitolata al barbiere) e corso di Porta Ticinese è presente una palazzina; in una rientranza della stessa nel 2005 vennero collocate una scultura in bronzo e una targa a ricordo degli eventi. Su questa targa è incisa una frase che lo stesso Manzoni scrisse nel libro a condanna di ciò che il popolino aveva fatto: “E’ un sollievo pensare che se non seppero quello che facevano fu per non volerlo sapere, fu per l’ignoranza che l’uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa ma una colpa”.











