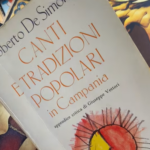Sembrerebbe quasi assiomatico che questa pandemia abbia cambiato e cambierà in futuro molte delle nostre consolidate abitudini di vita, tra cui anche l’uso che normalmente facciamo della nostra lingua, tenuto conto che le parole sono importanti per rivestire ogni nostra azione e dare senso ad ogni nostro comportamento.
Nel periodo del contagio (probabilmente i libri di storia riporteranno l’éra del Covid 19) alcuni termini risuonano costantemente in ogni conversazione o commento, analisi, e quant’altro.
Si usa cioè un lessico diremmo di tono bellico. I diversi discorsi sono infarciti continuamente di termini ed espressioni come ‘siamo in stato di guerra’, ‘dobbiamo sconfiggere il nemico’, ‘è un conflitto mondiale’, ‘la battaglia sarà lunga e dura’, ‘stiamo tutti in trincea’, ‘il nemico ci attacca senza tregua’, ‘dobbiamo predisporre armi di difesa’, ‘dobbiamo mettere in campo azioni di contrasto’, ‘ci sentiamo accerchiati’ e così via.
Questo richiamo linguistico di tipo militare si insinua non solo nel nostro “parlato” ma condiziona o può condizionare anche il nostro stato d’animo, predisporre cioè una condizione di vita che non si ispira certo alla fratellanza e alla solidarietà ma impone semmai un “cuore duro” e uno stato continuo di allerta.
Per quanto esterofilo possa essere il nostro Paese tuttavia va sottolineato che pur in presenza di un vocabolario di guerra, l’abitudine o la tentazione di usare termini ed espressioni non autoctone ma prese da quello strano e ormai endemico lessico che definiamo “italinglese”, non viene mai meno e anzi si rafforza ulteriormente.
Vediamo solo qualche esempio.
Il governo, tanto per dire, non nomina un gruppo di lavoro ma costituisce una ‘task force’, e se si deve provvedere ad isolare una città non si pensa di chiuderla ma di procedere ad un ‘lockdown’ (un termine carcerario americano), se poi si deve istruire a come evitare il contagio, che ovviamente si prende tramite ‘droplets’, si ricorre a dei ‘video tutorial’ mentre per gli strumenti e le attrezzature scolastiche si parla invece di ‘device’, così come per le scadenze varie imposte dalla situazione di emergenza si preferisce richiamarsi al ‘timing’, e poi se proprio si deve restare a casa a lavorare si impone o suggerisce lo ‘smart working’; ma non finisce qui poiché ci sono anche altri termini ricorrenti: ‘spillover’, ‘outfit’, ‘business’, ‘tag’, ‘recovery fund’, ‘corona bond’, ecc.
È significativo inoltre che persino un ente come l’Inps non abbia saputo resistere al richiamo anglofilo quando ha inserito nel proprio sito l’espressione ‘data breach’ che evidentemente è apparsa ai responsabili molto più fine dell’equivalente italiano “violazione dei dati”, il che ha fatto irritare, com’è giusto, anche l’Accademia della Crusca che è intervenuta con un comunicato ad hoc in cui dichiarava espressamente che non si può ignorare “un’espressione già regolarmente in uso dal Garante per la protezione dei dati e comunque presente nei testi normativi ufficiali a cominciare dalle versioni italiane dei regolamenti europei”.
E precisava: “non suggeriamo una parola nuova ma ci atteniamo a un equivalente già affermato che riteniamo non possa essere ignorato da chi comunica con il largo pubblico”.
Se è vero -com’è vero-, alla stregua degli insegnamenti di Ugo Foscolo, sono i grandi a ispirare “a egregie cose” 1’umanità di ogni tempo, vale la pena ricordare che il nostro paese è quello della lingua di Dante e Leopardi e pur con tutto il rispetto per le “vulgate” altrui sarebbe il caso, specie nei momenti più drammatici, di stringersi intorno alla straordinaria tradizione anche linguistica “locale” per tirar fuori lo spirito e il coraggio di riedificare un Paese in ginocchio.