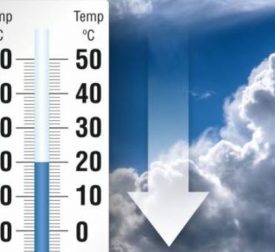La sequenza dei decreti emanati dal Governo nel periodo di guerra contro il coronavirus ha per comune denominatore l’uso di una rassicurante comunicazione: da “cura Italia” a “liquidità” e “rilancio”.
Il prossimo si chiamerà “semplificazione” e continuando sulla medesima lunghezza d’onda non è da escludersi per il successivo il titolo “rinascita”. Come semantica del conforto non c’è nulla da ridire, funziona per risollevare gli animi dalla depressione.
Altra cosa è la corresponsione di aspettative che non sembrano soddisfacenti secondo le manifestazioni poste in essere da parte dei destinatari delle misure restrittive e dei beneficiari dei provvedimenti di sostegno ai redditi dei più bisognosi ed ai titolari di attività congelate dalla crisi.
Al di là delle buone intenzioni del Governo, che non sono in discussione, dietro ciascuno dei citati decreti si intravede una carenza di fiducia e di ascolto del Paese reale, tacitato con gli scudi dei Comitati tecno-scientifici ed imbrigliato da una scrittura tortuosa e burocratica che contrasta con l’essenza della “cura” e del “rilancio” e della “liquidità” la cui disponibilità ne è il carburante.
E se le contestazioni sono un vezzo delle opposizioni politiche non si può dire la stessa cosa se esse provengono dai Sindaci e dalle categorie produttive del lavoro, arti, mestieri e professioni. Il che mette in dubbio rappresentatività ed autorevolezza di una leadership governativa che si dibatte tra tentazioni ideologiche e pragmatismi necessitati dalle concomitanti crisi sanitaria ed economica.
Si capisce il travaglio per la ricerca delle parole giuste del tipo “vedrai che tutto andrà bene”, c’è qualcuno che pensa per te. Un po’ meno comprensibili appaiono le direttive che oggettivamente prefigurano un regime di sorveglianza sulle facoltà di autocontrollo degli italiani ed un test di esame sulle loro attitudini e capacità a fare impresa.
Sul punto il dato certo è la depressione economica e sociale che ci lascia appresso una pandemia sulla cui gestione pesano le ombre dei dogmi politicamente corretti verso il governo dell’OMS reticente sui tempi di insorgenza dell’epidemia.
Quello che ora gli italiani vogliono sapere, o quanto meno conoscerne le linee guida, è il modello di sviluppo per il quale optare ed indirizzare mezzi e strumenti finanziari disponibili e reperibili e le risorse umane da valorizzare per know-how acquisito e/o da implementare.
L’emergenza ha un limite temporale e di indebitamento oltre il quale c’è il default se non si riprende il ciclo delle attività produttive e dell’universo di servizi che danno senso alla vita di comunità. Né basta appellarsi allo spirito che ha caratterizzato il nostro dopoguerra per pensare in positivo. Si tratta di una espressione puramente retorica, suggestiva ma priva di fondamenti paragonabili rispetto alla diversità di contesti ed obbiettivi. Quella Italia, affamata e con scarsi beni di prima necessità, ancora rurale per cultura e per assetto economico e sociale, aspirava ad uscire dall’autarchia per entrare nel circuito e nei mercati delle nazioni industrializzate.
Per spiccare il volo ha puntato su scelte coraggiose assunte da Alcide De Gasperi, personalmente, contro lo scetticismo della burocrazia dello Stato e con il conforto del Governatore della Banca d’Italia, Luigi Einaudi, e del Presidente di Confindustria, Angelo Costa: l’adesione nel 1946 agli accordi di Bretton Wood e l’anno dopo l’ingresso, tra i membri effettivi, nel Fondo Monetario e nella Banca Mondiale. Poi è arrivata la “benzina” del Piano Marshall per i motori della ricostruzione.
L’Italia di oggi, seconda potenza manifatturiera d’Europa e prima per esportazioni di prodotti di eccellenza, ha il problema di riaccendere i motori, liberandoli da bardature burocratiche e da condizionamenti ideologici; membro fondatore dell’EU bussa alle porte di Bruxelles per attingere risorse a debito da più fondi per far fronte all’odierna emergenza ma non riesce a spendere ed a rendere produttivi quelli strutturali già disponibili per infrastrutture ed implementare una nuova concertazione di politica industriale. Senza la quale quo vadis?
Per averne qualche indicazione, al momento, non ci resta che vestire i panni di Totò e Peppino e chiedere al “primo vigile di turno” a Palazzo Chigi: “Noi vogliamo sapere per andare dove vogliamo andare per dove dobbiamo andare”.